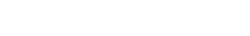ASTROLOGIA
SCIENZA, CREDENZA that is the question
Poche, forse nessuna, forme di conoscenza come l’astrologia fanno discutere dall’alba dei tempi, così come poche possono vantare altrettante alterne fortune.
Di volta in volta l’astrologia è stata rispettata o condannata, vista come importante connessione tra cosmo e vivente o come patologia sociale. Prima scienza del tempo, studiata, applicata, apprezzata da sapienti, sacerdoti, regnanti, uomini di cultura. Poi disprezzata, perseguitata da imperatori e papi, messa al bando, nell’Illuminismo, dalla dea Ragione.
Gli scienziati (senza nulla conoscere dell’astrologia) si ostinano a spiegarci che non è una vera scienza, uomini insigni ribadiscono che è stupida superstizione. L’astrologia, dalla sua nascita, non ha mai smesso, nel bene e nel male, di far parlare di sé, di far riflettere, indagare, analizzare, inveire, puntualizzare.
È esistito un periodo aureo dell’astrologia? Sicuramente. Possiamo fissarne il declino irrimediabile, la definitiva scomparsa? La risposta è negativa. L’astrologia nel linguaggio comune, nei media, nelle pubblicazioni, nell’immaginario collettivo è più viva che mai.
Qual è la sua forza o, per contro, qual è la debolezza dell’essere umano che volge lo sguardo alle stelle? Quale linguaggio adotta l’astrologo, che espressioni usa per far presa sulle persone, perché e come i media usano l’astrologia?
Dalla sua nascita, quando era scienza appannaggio di sacerdoti e sapienti, fino al nostro tempo, a una società che la vede massificata, presente su quotidiani, rotocalchi, ricerche di mercato, trasmissioni televisive, l’astrologia non ha mai cessato di essere incisiva.
“Non ci credo.” “Tutte sciocchezze.” “Ci prende sempre.” “Leggo sempre l’oroscopo.” “Leggo l’oroscopo per iniziare bene la giornata.” “Non ci credo, ma mi diverte”. Frasi tipiche, luoghi comuni che dimostrano la presenza dell’astrologia nella nostra società. Oggi, come nelle società passate.
Pur nella sua banalità e nell’ovvietà di molti testi o delle previsioni dell’astrologo televisivo di turno, l’astrologia affata. La volta del cielo non smette di affascinarci.
Quando l’uomo ha acquisito la forma eretta e ha reclinato la testa, si è messo, naso all’insù, a fissare la volta celeste. E da allora, non ha mai smesso.
Le stelle (in greco antico plànetes astéres, stelle vagabonde) si spostavano nel cielo notturno ponendo dubbi sul divino, sul finito e sull’infinito, sul senso della vita, dell’amore, della morte. L’uomo non cessa di interrogarle, di affidar loro sogni, desideri (de-sidera, “dalle stelle”) dubbi e paure. Perché? Solo per superstizione, per dabbenaggine, perché, come credevano i sofisti, l’uomo è legato al carro del caso o perché l’astrologia è un codice linguistico, un sistema, una modalità di lettura del vivente codificato da secoli e che, da secoli, avvince l’uomo?
L’astrologia è un fenomeno sociale, un linguaggio antico che fa tuttora presa ed è ben presente nel tessuto sociale e la sua diffusione, la sua presenza nella società contemporanea e nei mezzi di comunicazione sono sempre più profonde e capillari.
Leggere l’oroscopo ci piace perché ci arrivano messaggi rassicuranti che interpretiamo a piacimento. Messaggi che, veicolati dall’industria culturale, soddisfano il bisogno di svago, compensano temporaneamente una mancanza, diventando sottilmente manipolatori: come osserva Paolo Jedlowski,
“l’industria culturale porta la cultura alle masse. Sotto questa apparenza, tuttavia, si nascondono uno svuotamento della nozione stessa di “cultura” e un progetto di manipolazione. Che la cultura si svuoti significa che essa non è più – come nell’epoca della borghesia in ascesa – luogo privilegiato dell’elaborazione del senso e veicolo di aspirazioni ideali che trascendono l’ordine dato, bensì luogo di intrattenimento e, soprattutto, meccanismo di promozione dell’adattamento di ciascuno all’ordine sociale esistente. Quanto alla manipolazione, essa è insita nella logica di comunicazione di massa.” P. Jedlowski, Il mondo in questione, Carocci, Roma, 2009, p. 202
Seguendo la teoria critica del sistema culturale arriviamo alla tesi esposta da Adorno in “Stelle su misura”: l’astrologia arriva ad essere una dipendenza sociale e psicologica perché soddisfa un bisogno, ma può soddisfare questo bisogno perché i mass media hanno il potere di condizionare opinioni e comportamenti degli individui; come ci ricorda Saveria Capecchi,
“l’assunto principale della teoria degli usi e gratificazioni è che il pubblico usa i contenuti dei media allo scopo di ottenere determinate gratificazioni. Detto in altri termini, ogni individuo, sulla base dei propri bisogni – di derivazione psicologica e sociale – tende ad esporsi ai contenuti che presume possano soddisfare quei bisogni; ottenuta una particolare gratificazione, tenderà ad esporsi a quel genere di contenuto ogni qual volta sentirà l’esigenza di soddisfare lo stesso tipo di bisogno.” S. Capecchi, L’audience “attiva”, Carocci, Roma, 2004, p. 78
Uno dei motivi per cui molti mezzi di comunicazione di massa hanno aperto le porte a questa astrologia popolare è da vedersi, credo, anche in quel substrato di rilancio culturale che si era amplificato alla fine dell’Ottocento e nei primi del Novecento soprattutto negli ambienti esoterici (pensiamo a Gurdjieff, Helena Blavatsky, i Rosacroce, la Golden Dawn) Accanto a questa esplosione che potremmo definire genericamente “esoterica spiritualista”, il successo che nel decennio immediatamente precedente alla guerra ormai hanno conquistato le scuole psicanalitiche – freudiana e junghiana – aveva in un certo senso spalancato le porte ad un ritorno potente del linguaggio simbolico e di tutta una cultura basata sull’uso del simbolo di cui l’astrologia certamente fa parte. Si pensi anche negli anni Venti e Trenta al grande successo europeo soprattutto francese ma anche americano di avanguardie artistiche come il dadaismo e il surrealismo. Il movimento Dada – da Tzara a Duchamp, a Grosz – porta in prima linea nell’esperienza artistica il tema del caso e della sincronicità e il surrealismo fa del simbolico del sogno uno dei suoi fulcri centrali. In questo substrato culturale letterario, artistico, psicanalitico si trova l’humus, il retroterra che sarà sfruttato da un punto di vista di massificazione e traduzione popolare dell’astrologia, non certo propugnata come materiale di cultura, ma come strumento di conquista e fascinazione popolare, occasione che i media più scaltri e intelligenti non si lasceranno sfuggire. Inutile sottolineare che la possibilità di molti lettori di identificarsi in un “segno” piace molto perché realizza una facile e anche gratuita appartenenza di gruppo basata su caratteristiche e tipologie di base semplici e un linguaggio altrettanto semplice (su cui indirizza i riflettori la critica adorniana).
Ma perché un oroscopo rafforza l’identità personale e sociale? Perché questa antica disciplina, così profonda, ricca di spunti, tra il cosmologico e il simbolico, luogo di cultura e di storia ha una risposta così eclatante dal punto di vista popolare in ogni ceto sociale, in ogni epoca, sia negli adulti che nei giovani?
Perché in un’epoca come quella della società industriale, capitalistica, analizzata da Adorno e da Barthes, fra i tanti, una società che spersonalizza e in cui l’individuo perde l’identità diventando una sorta di macchina, di numero, come mai in questa società ha successo l’astrologia? Perché continua ad essere seguita nell’odierna società, che Bauman definisce liquida, incerta, frustrante?
In questa spersonalizzazione, in questa crisi di identità il riconoscerci in qualcosa, il poter creare una micro socialità e una possibilità di identificazione individuale è indubbiamente molto rassicurante.
L’astrologia è rassicurante, rafforzativa ed esaltante. Noi siamo dell’Ariete, noi siamo del Toro, noi siamo qualcuno. Noi ci riconosciamo. In una società in cui gli individui non si riconoscono più e non sanno più chi sono e quindi sono costretti ad assorbire dei modelli che spersonalizzano e che sono recepiti in un modo del tutto passivo (la star del rock, il rampante, il calciatore, il ricco, la velina) l’astrologia fornisce un’identità rassicurante, comune, condivisibile. La società capitalistica sforna modelli di successo, modelli quasi irraggiungibili, modelli troppo alti a fronte di una realtà che ti costringe a una quotidianità fatta di lavori duri, di proletariato (adesso di disoccupazione, esodati, cassintegrati). Questa spinta identificativa ai modelli sociali presuppone un vuoto di identità. La gente non sa più chi è. Tutto ciò in parallelo alla crisi della sfera religiosa, alla secolarizzazione, all’impossibilità di sfruttare ambiti culturali come la psicanalisi, che è una via di conquista dell’individualità e dell’identità individuale, ma è una via costosa, fuori portata per molti.
In questo vuoto di identità e di identificazione ecco che la bassa astrologia dei 12 segni funziona come ambito identificativo alla stessa stregua dell’identificazione per i maschi in una squadra di calcio. Io mi identifico nell’Inter, nel Milan e quindi aderisco a una passione solo perchè la società non mi offre altro. Così io trovo una risposta ai miei dubbi di identità sapendo che sono dei Gemelli o del Cancro. Questa identificazione con un simbolo collettivo, ha una funzione estremamente rassicurante. Certo che sono orgoglioso, sono del Leone. Certo che faccio fatica a conquistare gli obiettivi alti, potrei ridimensionarmi. Ma mi pongo obiettivi alti perché, in quanto appartenente al segno del Leone, sono ambizioso, esibizionista e quindi la mia identità ha questo difetto di essere un po’ piena di sé: sono del Leone.
L’identificazione con il simbolo astrologico assume una funzione che placa le angosce dell’Io (perché mi sento rassicurato, non sono il solo ad avere questi difetti del carattere, siamo in tanti del Leone e questo mi rassicura); identificarsi in un segno rassicura l’esaltazione dell’Io in quanto il proprio segno ha tutta una serie di qualità ad esempio (da un punto di vista femminile) la Bilancia ha la qualità dell’eleganza, dell’estetica, il gusto dell’arte, la raffinatezza delle forme, bontà d’animo di cuore, capacità di creare dei grandi amori ideali, la capacità di sacrificarsi per amore. L’astrologia esalta il mio Io. L’astrologia mi dice che io, Bilancia, ho tante belle qualità, ma ha anche la funzione di rendere meno pesanti i miei difetti. È vero io vado in crisi perché sono dubbiosa, esitante, incerta, sono troppo rigida, a volte troppo critica con me stessa, ma son della Bilancia, quindi siamo tutte così, non sono la sola ad avere questi dubbi.
L’astrologia ha questa funzione consolatoria. Una funzione esaltante, ma parallelamente anche consolatoria. Detto questo, sempre in sintonia con i modelli del sociale.
Accanto al vuoto d’identità l’astrologia ha la funzione di far sentire gli individui meno soli, meno affaticati e meno angosciati rispetto al lavoro di controllo, autocontrollo e gestione della propria dubbiosa identità. Certo siamo di fronte a un’astrologia bassa, commerciale, becera rispetto alle altezze rinascimentali o al Poema degli Astri di Manilio, ma siamo di fronte a una funzione sociale dell’astrologia, che piaccia o no, che i media amplificano.
L’astrologia diventa così quasi come l’oppio dei popoli che Marx assegnava alla religione, se pensiamo alla ricerca adorniana; astrologia come lingua di un discorso tra il vivente e il Tempo per gli studiosi della materia; astrologia come congiunzione tra arte, scienza delle stelle e universo fisico:
“non appena ci arrendiamo all’intuizione che l’astrologia significa solo una ipertrofia della potente e chiaramente articolata immagine del mondo dell’astronomia greca, il cui fondamentale impianto armonico neppure una fantasia così demonicamente sviata può distruggere, ci sta di fronte il cosmo dell’antichità” A. Warburg, Per monstra ad sphaeram, ABSCONDITA, Milano, 2009, p. 53
L’astrologia raccoglie tanti echi, fa convergere o scontrare arte e scienza, religione e filosofia, razionalità e superstizione. L’astrologia scandisce le epoche, segue il cammino dell’uomo, l’evolversi della società. La sua forza, credo, sta in questo muoversi tra tradizione e contemporaneità come se non esistessero scansioni temporali. Noi guardiamo lo stesso cielo che vedevano i nostri antenati e anche se il cielo stellato è diventato meno misterioso, popolato non di miti, dei e mostri, ma da fredde luci che osserviamo distrattamente, la sua magia rimane. Inalterata.
L’arte di interpretare le stelle, vista dalla sociologia a volte come strumento di condizionamento, altre come assopimento della coscienza o messaggio consolatorio, non dovrebbe scatenare ire o disprezzo ma studiata perché è un potente motore di conoscenza:
“le ricerche storiche non devono rinunciare a padroneggiare e a comprendere una disciplina per la quale sono stati spesi più tempo, pazienza, intelligenza e denaro che per qualunque altra disciplina veramente scientifica” F. Boll e C. Bezold, Le stelle, cit. p. 4